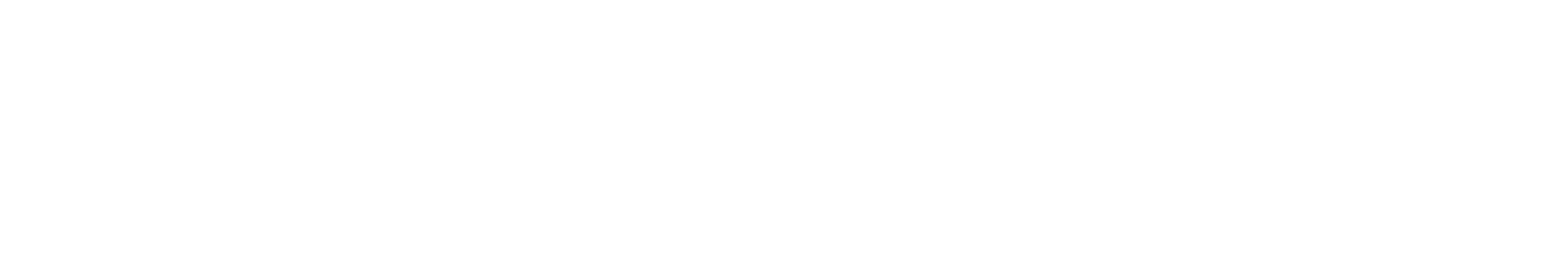Questa mattina, 2 marzo, la comunità delle Suore del Getsemani ha vissuto un momento di grazia con la Visita pastorale dell’arcivescovo Gian Franco, in occasione del ritiro precapitolare. È stato un incontro segnato dalla preghiera, dall’ascolto e dalla condivisione fraterna, nel corso della quale l’Arcivescovo ha rivolto alle religiose parole di incoraggiamento e di riflessione sul loro cammino di consacrazione e servizio.
Nel suo intervento, l’Arcivescovo ha detto:
«Rendiamo grazie al Signore per il dono della giornata trascorsa insieme, un dono per me molto prezioso. Rivolgo un affettuoso saluto a Madre Maria, ringraziandola per le parole di accoglienza e per il prezioso servizio di guida alla comunità, svolto con sapienza e dedizione. Saluto con gratitudine ciascuna di voi, impegnate nella comune missione. Sono lieto di partecipare a questo incontro, espressione di un legame d’affetto nei vostri confronti, del vostro carisma e della vostra presenza viva nella Chiesa locale.
La missione della grazia si manifesta nella vicinanza, nella partecipazione concreta alla vita di questa comunità. La vostra presenza è un segno significativo, radicato in un contesto peculiare che ne conserva la qualità e l’unicità. Essa diventa un aiuto nel cammino della Chiesa particolare, testimoniando l’importanza di un impegno condiviso.

Riflettiamo oggi su un passo evangelico che può illuminare il nostro percorso: Matteo 26,36 e seguenti, che racconta l’esperienza di Gesù nell’orto del Getsemani. È un testo che ci accompagna nella riflessione spirituale e pastorale, in relazione anche ai carismi della vita religiosa. L’aspetto materno del vostro carisma trova qui una particolare sintonia con l’atteggiamento di Cristo.
Il brano evangelico ci racconta come Gesù, giunto al Getsemani, disse ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. Prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo e cominciò a provare tristezza e angoscia. In questo episodio si evidenzia un aspetto centrale della vita di fede: il bisogno di preghiera di fronte alle prove più grandi. La preghiera non è un’evasione dalla realtà, mauno sguardo rivolto a Dio che ci aiuta a contemplare il mistero della nostra vita alla luce della sua presenza.

Nel Getsemani, Gesù vive un momento di profonda consapevolezza della sua missione. Ne percepisce tutto il peso e sente il bisogno della preghiera, il desiderio di rivolgere lo sguardo al Padre. La preghiera diventa così un’esigenza costante, un atto di fiducia e di abbandono. Egli si rivolge ai discepoli con parole di grande intensità: “La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me”. Questo invito richiama alla comunione profonda con Cristo, una comunione non fatta di gesti estemporanei o di occupazioni momentanee, ma di un’esistenza totalmente coinvolta nella volontà del Padre.
L’evangelista Matteo sottolinea come, nei momenti decisivi, Gesù scelga sempre la preghiera e la comunione con il Padre. Fin dall’inizio della sua vita pubblica egli manifesta questa esigenza: “Non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio?” (Lc 2,49). È un’indicazione chiara: la sua missione è radicata in una relazione intima con il Padre, che diventa il modello per ogni discepolo.
Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, invitandoli a seguirlo da vicino. Questo gesto suggerisce una progressione nel cammino della sequela: egli vuole coinvolgerli nel suo stesso percorso, preparandoli alla loro futura missione. Tuttavia, i discepoli faticano a comprendere e a restare svegli: l’esperienza della prova li coglie impreparati. Anche questo ci riguarda da vicino: spesso la nostra sequela è intermittente, segnata da momenti di entusiasmo e da momenti di debolezza. Ma la fedeltà di Gesù resta salda ed egli continua a chiamare i suoi discepoli alla comunione con lui.
Nel Getsemani emerge anche una tensione profonda tra il desiderio umano di sottrarsi alla sofferenza e l’obbedienza alla volontà del Padre: “Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu”. Questo è il grande “sì” di Cristo, un sì totale, pieno e senza riserve. È il fiatche lo conduce fino alla croce, ma anche alla resurrezione. Gesù non fugge dal dolore, bensì lo attraversa con fiducia, trasformandolo in offerta d’amore.

Questa esperienza ci insegna che la missione cristiana non si fonda su logiche di potere o di successo umano, ma sulla donazione di sé. Gesù rifiuta il modello di un Messia terreno che venga soltanto per sfamare il popolo. Come avviene dopo la moltiplicazione dei pani, egli offre un altro pane, il pane della sua stessa vita, e chiede ai discepoli di fare altrettanto: “Date voi stessi da mangiare”. Qui si manifesta il cuore della vocazione cristiana: non si tratta semplicemente di compiere azioni, ma di diventare noi stessi pane spezzato per gli altri.
Nel Getsemani, Gesù affronta anche la solitudine e il tradimento. È circondato da persone con attese diverse, da chi lo segue per interesse e da chi non comprende appieno la sua missione. Questa è una prova dura, ma egli non si lascia sopraffare. Anche nei momenti di maggiore abbandono la sua fiducia nel Padre non vacilla. Questo ci insegna che la fedeltà alla vocazione richiede un radicamento profondo nella preghiera e nella comunione con Dio.
Il cammino pasquale è sempre segnato dalla prova. Il Getsemani non è la meta ultima, ma una tappa da attraversare. È il luogo della decisione definitiva, della resa totale alla volontà del Padre. È una sfida anche per noi: siamo chiamati a vivere la nostra vocazione non con la logica del “si è sempre fatto così”, ma con un discernimento autentico, capace di leggere i segni dei tempi e di rispondere con creatività e fedeltà.
Oggi, nella Chiesa, il tema della vocazione è particolarmente attuale. La diminuzione delle vocazioni sacerdotali e religiose non è solo un problema numerico, ma un segno dei tempi che ci interroga. Forse è il momento di riscoprire il carisma della chiamata, di comprendere come il Signore continui a parlare anche nelle situazioni di apparente aridità. Il Vangelo ci mostra che la missione di Gesù non è stata accolta facilmente: anche lui ha incontrato resistenze, fraintendimenti e opposizioni. Maproprio in questa lotta si manifesta la verità della vocazione cristiana.
Nel Getsemani, Gesù sperimenta la tristezza e l’angoscia, ma non si lascia vincere dalla paura. Egli si abbandona al Padre e, proprio in questo atto di fiducia totale, trova la forza per andare avanti. Questo ci insegna che la nostra missione non si compie con le sole forze umane, ma nella docilità allo Spirito Santo. È lo Spirito che ci rende capaci di dire il nostro “sì” a Dio anche nelle prove più difficili.
La Chiesa di oggi ha bisogno di uomini e donne che sappiano stare nel Getsemani del mondo, testimoniando un amore che non si arrende e che non si lascia scoraggiare dalle difficoltà. L’evangelizzazione in un contesto secolarizzato richiede questa capacità di perseverare, di credere che anche nella notte Dio èpresente.
Il Getsemani non è solo un luogo di sofferenza, ma anche di speranza: è il luogo dove il sì di Gesù apre la strada alla redenzione.
Alla luce di questa riflessione il discernimento vocazionale assume una rilevanza ancora maggiore. Il nostro impegno non può essere soltanto organizzativo o burocratico, ma deve essere radicato in un’autentica ricerca di Dio. Il nostro tempo chiede testimoni credibili, persone capaci di vivere il Vangelo nella concretezza della vita quotidiana.
Gesù, nel Getsemani, ci insegna che la vera vittoria non sta nell’evitare la croce, ma nel fidarsi del Padre fino in fondo. Questa è la sfida della nostra vocazione: accogliere il mistero della volontà di Dio e lasciarci trasformare dal suo amore».