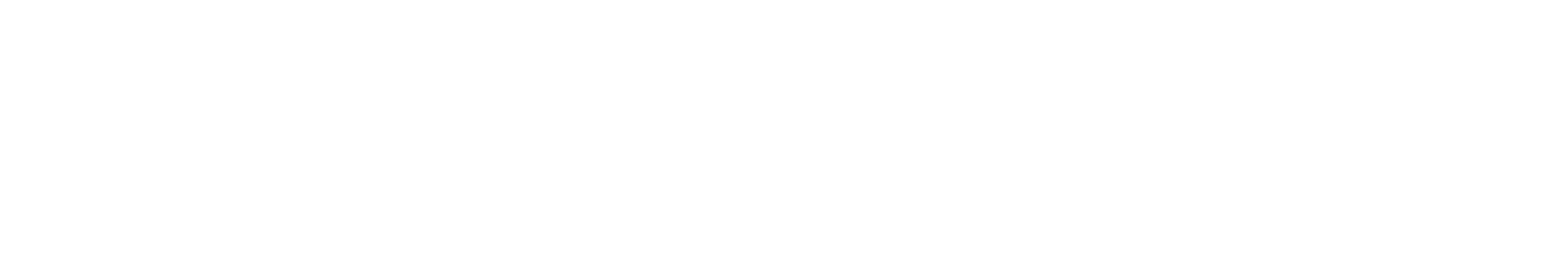Nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio, la Chiesa Turritana si è riunita per una serata di preghiera e discernimento sullo Strumento di lavoro per la fase profetica, trasmesso alle diocesi italiane dalla Segreteria Nazionale del Cammino Sinodale.
L’incontro è stato un’occasione per pregare insieme e proseguire il cammino, riflettendo sulle priorità emerse dalle diocesi italiane. Come ricordato dal Vicario Generale, Mons. Marco Carta, nella convocazione, questo appuntamento si inserisce nel percorso di preparazione alla Seconda Assemblea Sinodale delle Chiese in Italia. Sulla base dei contributi ricevuti, il Comitato Nazionale del Cammino Sinodale presenterà un documento che delineerà le priorità emerse e definirà i tempi per la loro attuazione a livello nazionale, regionale e diocesano.
L’appuntamento si è aperto con i saluti di Mons. Marco Carta e con la preghiera nella Chiesa del SS. Sacramento. Prima dell’intervento dell’Arcivescovo Gian Franco, è stato letto un estratto dallo Strumento di lavoro per la fase profetica della CEI:
“La Prima Assemblea Sinodale ha confermato e rafforzato l’esigenza di una riforma ecclesiale che comporta una triplice conversione, delineatasi sempre più chiaramente come conversione comunitaria, personale e strutturale (cf. Evangeliigaudium, 27).
La conversione comunitaria si prospetta con una specifica attenzione a un fare cultura che non resti confinato nelle accademie, ma che sappia raccogliere le innumerevoli esperienze evangeliche vissute nelle nostre comunità, fondarle, esprimerle con linguaggi comprensibili e attuali, e mostrarne la bellezza.
La conversione personale si favorisce attraverso la cura della formazione cristiana a tutti i livelli: l’evangelizzazione, l’iniziazione cristiana (tema particolarmente sentito dalle Diocesi), la catechesi degli adulti, le varie forme di annuncio (anche nelle case e negli ambienti di vita), la lectio divina, l’accompagnamento spirituale e gli itinerari teologici strutturati.
La conversione strutturale passa attraverso la corresponsabilità ecclesiale, con il rilancio dei ministeri laicali e degli Organismi di partecipazione, la riforma delle Curie, la valorizzazione dell’apporto delle donne anche nei ruoli di guida e una gestione più adeguata delle strutture materiali, amministrative e pastorali, spesso troppo pesanti e sovradimensionate.
Non si tratta, dunque, nella fase profetica, di mettere a fuoco l’intero ventaglio dei temi pastorali, ribadendo in modo compilativo l’importanza di tutti gli ambiti e i settori della vita pastorale. Si tratta piuttosto di affrontare i nodi che permettono di sbloccare alcune dinamiche ecclesiali, o persino clericali, refrattarie alla sinodalità. In altre parole, occorre concentrarsi sulle condizioni di possibilità per comunità più evangeliche e missionarie, riformando meccanismi divenuti eccessivamente pesanti rispetto alle esigenze della testimonianza del Risorto nel mondo di oggi.
Dire fase profetica significa riattivare quella Pentecoste che fu un evento di popolo, non di singoli. Tutti sentivano i primi predicatori parlare la propria lingua. E Pietro, spiegando l’incredibile accaduto, riconobbe in esso l’adempimento della profezia di Gioele:
“Negli ultimi giorni – dice Dio – su tutti effonderò il mio Spirito; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno” (At 2,17-18; cf. Gl 3,1-2).
Di seguito riportiamo l’intervento dell’Arcivescovo Gian Franco:
«Grazie per quest’ulteriore tappa che condividiamo, portando avanti l’esperienza del Cammino Sinodale e aprendoci alla dimensione profetica o, meglio, risvegliando quella grazia che abbiamo ricevuto con il Battesimo. Con il dono dello Spirito Santo, infatti, è stato dato un popolo sacerdotale, profetico e reale. Un popolo profetico è un popolo animato dalla Parola, quella Parola che lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, fa risuonare nel cuore di ciascuno e nella realtà concreta della nostra vita.
Il testo degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato, e che tante volte è stato oggetto della nostra riflessione e preghiera, ci dice che, mentre si stava compiendo il giorno della Pentecoste, i discepoli si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Ma a quale Pentecoste si riferisce l’autore del testo? Quale Pentecoste si sta compiendo nel calendario di chi vive quell’esperienza? E quale nuova Pentecoste si innesta dentro quel calendario?
Questo è un dato importante, perché ci aiuta a connettere il cammino di Dio con la storia dell’umanità e con i nostri processi storici. La parola “processo” – dal latino processus, ossia camminare, procedere – è ormai entrata nel nostro linguaggio comune: il Sinodo e il Magistero ce l’hanno consegnata. Ma dobbiamo diventarne sempre più consapevoli, comprendere il suo significato profondo. Anche le persone di cui parla l’autore degli Atti si trovano dentro un processo. Stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovano a Gerusalemme per una festa molto importante, ma forse non si aspettavano quello che sarebbe accaduto.
La Parola di Dio e i Profeti ci introducono sempre nella storia, ci inseriscono nel calendario storico per aiutarci a scorgere con gli occhi della fede ciò che avviene nel tempo e nella realtà che viviamo. Se il processo sinodale si limitasse solo all’analisi delle situazioni, alla formulazione di ipotesi e alla stesura di un elenco di cose da fare, sarebbe ancora insufficiente. Non sarebbe sbagliato, certo, ma il nostro cammino è chiamato a entrare nella novità di Dio, nella sua opera, nell’azione del Signore.
Il testo ci dice che i discepoli erano tutti insieme, ma non necessariamente concordi. Più avanti si parlerà degli effetti della Pentecoste, ma qui è ancora un raduno, un ritrovarsi. Luca è molto preciso: sottolinea che erano insieme, nello stesso luogo, nel contesto di una festa solenne della liturgia ebraica. Questo è un dettaglio importante, perché ci permette di immedesimarci in quella scena e di compiere una sorta di elaborazione fotografica di quel momento.
Immaginiamoci lì, con quel gruppo, nell’attesa. Ed ecco che all’improvviso, senza preavviso, dal cielo giunge un fragore, descritto come un vento impetuoso che riempie tutta la casa. Il linguaggio è apocalittico: il vento impetuoso sconvolge, riempie lo spazio, crea turbamento. Proviamo a immaginare se, proprio ora, questa stanza si riempisse di vento e di un forte rumore: sarebbe un’esperienza che ci scuote dentro. Ed è proprio questo che accade agli Apostoli. Questo evento produce in loro una trasformazione: iniziano a parlare. Ha inizio il cammino della Parola, della Parola suscitata dallo Spirito.
Prima erano lì, in silenzio, in un ambiente apparentemente tranquillo e ordinato. Poi, improvvisamente, accade qualcosa che li tocca profondamente e che li spinge a esprimersi. E non parlano con parole proprie, ma in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Questo è un punto centrale: il potere di esprimersi viene dallo Spirito. Non è una capacità personale, non è il risultato di uno studio o di un corso di lingue. È un dono, è lo Spirito che apre a un nuovo linguaggio, differenziato e personalizzato.
Anche noi oggi siamo chiamati a invocare lo Spirito affinché ci dia la parola, affinché susciti in noi parole che vengono da Lui. Non tutte le parole che pronunciamo vengono dallo Spirito di Dio. Discernere ciò che viene dall’alto e ciò che viene dal basso è una dinamica fondamentale nella vita della Chiesa, nella vita personale e nella vita comunitaria. Gesù stesso, unto dallo Spirito Santo, ha più volte sottolineato l’importanza di percepire ciò che viene dallo Spirito. E senza questo discernimento, la fase profetica rischia di ridursi a una mera fase programmatica. È necessaria, certo, ma non basta: serve un coinvolgimento autentico della persona, che sia toccata dentro, nei suoi sensi, che arda di un fuoco interiore e che da questo fuoco nasca la Parola.
Non è sempre facile discernere le parole che vengono dallo Spirito e quelle che invece provengono da altro. Anche nella Chiesa può accadere di pronunciare parole che non vengono da Dio. La Chiesa, in quanto semper reformanda, è chiamata a passare attraverso questo fuoco dello Spirito. Solo ciò che nasce da Dio può generare strumenti e mezzi conformi alla sua grazia; al contrario, ciò che nasce da una logica puramente umana rimane sterile. Siamo davvero disposti a lasciarci sconvolgere dallo Spirito?
Anche gli Apostoli fecero quello che potevano. Anche noi, stasera, facciamo quello che possiamo, secondo i nostri calendari, le nostre comprensioni. Ma quale passo lo Spirito ci sta suggerendo? Quale passo indica oggi alla Chiesa Turritana? Da quale Spirito dobbiamo lasciarci guidare per compiere un itinerario profetico?
Papa Francesco, nell’Evangelii Gaudium (275), sottolinea che l’azione misteriosa del Risorto e del suo Spirito apre sempre a una nuova stagione di missione ed evangelizzazione. La Risurrezione non è un evento del passato, ma una forza presente, viva, senza eguali. “Il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola” (Mc 16,20). Quando i discepoli partono per predicare, è il Signore stesso che agisce con loro. È questa presenza che apre a una nuova esperienza e a una nuova profezia.
Non lasciamoci prendere dall’ansia dei numeri. Il Vicario Generale ha parlato di questa équipe come di una sorta di consiglio pastorale allargato, e ha ragione. Siamo una comunità apostolica di discepoli che, attorno al Vescovo, desiderano riscoprire il piacere della missione, della Chiesa, dell’annuncio. Siamo chiamati a vivere una nuova stagione, un nuovo Kronos che diventa Kairos, un’opportunità di grazia».
I lavori sono poi proseguiti nei locali del Centro di Alta Formazione “Padre Manzella” della Fondazione Accademia, con la suddivisione in gruppi tematici. I partecipanti hanno approfondito i contenuti dello Strumento per la fase profetica, elaborando proposte per il proseguimento del Cammino Sinodale come Chiesa particolare.